 Più parlo con le colleghe e più avverto un montante senso di insoddisfazione e rabbia: le cose non funzionano, le persone sono sempre più disperate, i servizi sono sempre meno e con sempre meno soldi… e in mezzo a tutto questo l’assistente sociale ci deve mettere la faccia. Il rischio di saltare è dietro l’angolo. Ma siamo destinate ad essere sopraffatte dagli eventi o possiamo immaginarci delle strategie di “messa a terra”?
Più parlo con le colleghe e più avverto un montante senso di insoddisfazione e rabbia: le cose non funzionano, le persone sono sempre più disperate, i servizi sono sempre meno e con sempre meno soldi… e in mezzo a tutto questo l’assistente sociale ci deve mettere la faccia. Il rischio di saltare è dietro l’angolo. Ma siamo destinate ad essere sopraffatte dagli eventi o possiamo immaginarci delle strategie di “messa a terra”?
Per evitare che un apparecchio elettrico accumuli troppa tensione e si bruci ci sono degli appositi dispositivi che aiutano a scaricare al suolo l’energia in più. E per evitare che un assistente sociale si bruci (o che vada in burn out, per dirla in inglese) che cosa possiamo fare?
Innanzitutto partiamo col riconoscere che la situazione di crisi è reale e non è il frutto della fantasia degli operatori. Come ci ha chiaramente illustrato la prof.ssa Bifulco nel corso di un recente convegno a Milano, dal 2008 stiamo assistendo ad un aumento dei bisogni portati dai cittadini (freccia in su) e a una contrazione delle risposte date dal sistema di welfare (freccia in giù). All’incrocio di queste due opposte tendenze si colloca la sedia dell’assistente sociale.
All’incrocio di queste due opposte tendenze si colloca la sedia dell’assistente sociale.
Quando siamo nei nostri uffici, davanti a noi stanno le persone e dietro di noi c’è il welfare: noi siamo in mezzo. Come possiamo riuscire a starci?
Io ho provato a darmi delle risposte. E mi sbilancio a condividerle con voi perché mi piacerebbe avere un vostro riscontro.
> Primo pensiero: evitiamo di portare tutte le croci dell’umanità. 
Perché se è vero che l’assistente sociale è il punto di incontro tra persone e welfare, non si identifica né con l’uno né con l’altro.
Provo a tradurlo in due “sotto-pensieri”.
- Che il nostro welfare sia frammentato, categoriale, disomogeneo e iniquo è cosa nota (vedi “Chi ricompone i frammenti di welfare?” o “Povertà: il puzzle del welfare italiano“). Ma d’altra parte non ce lo siamo inventati noi e non ci dobbiamo sentire in colpa per il fatto che è pieno di pecche. Quello che possiamo fare è rendere il tutto più umano, mettendoci dalla parte del cittadino (l’esatto contrario di quello che fanno gli operatori dell’ufficio in cui va Daniel Blake, vedi il trailer).La nostra responsabilità è quella di aiutare il cittadino a capire che cosa può avere da questo welfare, sostenerlo nella messa a fuoco dei suoi bisogni, informarlo dei suoi diritti e traducendogli i complicati meccanismi burocratici in qualcosa di accessibile. Comprendendo la sua frustrazione di doversi muovere in un sistema così complicato, perché è anche la nostra frustrazione. Ma evitando di soffiare sul fuoco della disperazione, perché se chi entra nel nostro ufficio esce ancora più deluso non gli abbiamo reso un gran servizio.
- Che certe situazioni siano così disperate da non saper da che parte cominciare è esperienza comune. Ma che l’assistente sociale sia il responsabile delle storie di vita di chi gli sta davanti… mi sembra un salto logico un po’ eccessivo. Anche se spesso ce lo sentiamo dire. Ricordo un colloquio con un signore che al primo incontro mi ha portato l’ordinanza di uno sfratto esecutivo disposto per la settimana successiva.
“Ho bisogno di una casa popolare”
“… ecco, prima dobbiamo capire un attimo…”
“Allora io prendo i miei figli, vado a dormire sotto un ponte e so chi ringraziare”
“…?!?…”
Forse dobbiamo capire di quali responsabilità stiamo parlando. La nostra è quella di offrire alle persone uno spazio di pensiero, di proporre riletture di situazioni apparentemente già definite, di aiutare a connettersi con i soggetti della propria rete, di far conoscere altre nuove possibilità da attivare, di capire insieme che cosa fare. Insieme, per l’appunto, cioè partendo dalle persone, senza sentirci inadeguati se non estraiamo improbabili conigli dal nostro cilindro.
> Secondo pensiero: evitiamo l’autocensura.
 Perché se è vero che lavorare in un ente locale vuol dire avere a che fare con vincoli di bilancio, dobbiamo stare attenti a non confondere il livello della valutazione sociale con quello della valutazione economica. Altrimenti rischiamo di misconoscere i bisogni dei cittadini e di tradire il nostro mandato professionale, con conseguenti sensi di colpa e di inadeguatezza.
Perché se è vero che lavorare in un ente locale vuol dire avere a che fare con vincoli di bilancio, dobbiamo stare attenti a non confondere il livello della valutazione sociale con quello della valutazione economica. Altrimenti rischiamo di misconoscere i bisogni dei cittadini e di tradire il nostro mandato professionale, con conseguenti sensi di colpa e di inadeguatezza.
Provo a tradurre in concreto: un cittadino viene al servizio sociale perché vuole mettere la mamma in casa di riposo e ha bisogno di un aiuto economico da parte del Comune. Non fa in tempo a finire di parlare che in testa mi si accende l’allarme rosso al grido di “e dove li troviamo i soldi?!”. Ma se dessi parola a questi pensieri farei male il mio lavoro.
Quello che dovrei fare è presentare il Regolamento che disciplina le erogazioni economiche del Comune (perché ce l’abbiamo tutti, vero?), spiegare bene come funziona l’iter e che ci sono due passaggi: prima una valutazione sociale rispetto alla necessità di un inserimento in struttura e poi una valutazione economica rispetto alla sostenibilità della spesa stanti i vincoli di bilancio.
Se partissi dal fatto che non ci sono soldi, non mi darei il tempo di valutare se c’è il bisogno. Ma se il bisogno c’è, noi dobbiamo riconoscerlo e chiedere le necessarie risorse economiche. Se queste non possono o vogliono essere trovate, sarà responsabilità di qualcun altro metterlo per iscritto.
> Terzo pensiero: portiamo la nostra esperienza sui tavoli decisionali.
 Perché è vero che siamo lo street level burocracy. Ma ogni tanto sediamo anche nelle stanze dei bottoni: parliamo con i nostri superiori, con i politici locali, con i colleghi dell’Ufficio di Piano… In tutte queste situazioni possiamo dare un riscontro di quanto succede alla cittadinanza, di che cosa funziona e di che cosa no, dell’impatto delle varie misure di welfare e dei bisogni scoperti. Per essere propositivi ed evitare che i nostri mal di pancia restino al livello dell’arrabbiatura quotidiana.
Perché è vero che siamo lo street level burocracy. Ma ogni tanto sediamo anche nelle stanze dei bottoni: parliamo con i nostri superiori, con i politici locali, con i colleghi dell’Ufficio di Piano… In tutte queste situazioni possiamo dare un riscontro di quanto succede alla cittadinanza, di che cosa funziona e di che cosa no, dell’impatto delle varie misure di welfare e dei bisogni scoperti. Per essere propositivi ed evitare che i nostri mal di pancia restino al livello dell’arrabbiatura quotidiana.
Un altro luogo che andrebbe frequentato è l’Ordine: avete visto che cosa ha fatto quello lombardo a proposito della riforma sanitaria regionale? Ha presentato alla Regione una proposta di riconoscimento del ruolo degli as, trasformando i malumori di tanti colleghi in una richiesta esplicita da discutere.
E se facessimo la stessa cosa rispetto agli altri interventi legislativi regionali? Da lombarda, penso ad esempio alla “Misura B2” o al sedicente “Reddito di Autonomia”: ci piacciono? funzionano? rispondono ai bisogni dei cittadini che incontriamo? Ecco, credo che dovremmo imparare a fare lobby nel senso migliore del termine: cioè a rappresentare gli interessi dei “nostri” utenti agli occhi di chi decide, perché vengano messe in campo misure più sensate e praticabili.
Su scala nazionale lo stesso discorso vale per l’ISEE, per il SIA e per tutti gli altri acronimi con cui abbiamo a che fare. E se provassimo a dire la nostra?
> Ultimo pensiero: non abbiamo bisogno di più soldi, ma di spenderli meglio.
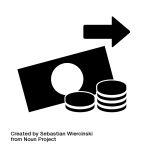 Da quando è cominciata la crisi si è diffuso in ogni dove il tormentone del “non ci sono soldi”. E’ un argomento che mette tutti a tacere perché appare come una verità inopinabile, ma a me sembra invece una trappola per inibire ogni immaginazione.
Da quando è cominciata la crisi si è diffuso in ogni dove il tormentone del “non ci sono soldi”. E’ un argomento che mette tutti a tacere perché appare come una verità inopinabile, ma a me sembra invece una trappola per inibire ogni immaginazione.
Proviamo a ribaltare la prospettiva: immaginiamo che i soldi che ci sono ci bastano e concentriamo le nostre rivendicazioni rispetto a come spenderli. Non dimentichiamo che siamo una nazione che garantisce l’assegno di accompagnamento anche ai miliardari (la bellezza di 508€ x 12 mensilità), mentre ci sono famiglie che si indebitano per pagare la badante alla nonna. Forse si potrebbero fare scelte diverse? Ci sono parecchie analisi molto serie che vanno in questa direzione.
Leggete questo articolo che propone di usare diversamente i soldi che sono stati messi nella legge finanziaria per il 2017, spendendolo per potenziare i servizi per l’infanzia invece che per dare bonus alle famiglie, che risultano essere iniqui e inefficaci.
Oppure quest’altro articolo che spiega la proposta elaborata dall’Istituto di Ricerca Sociale (IRS) per riformare la spesa sociale senza spendere un euro in più.
Poi, certo, se ci fossero più soldi potremmo fare ancora più cose. Ma non lasciamo che questo obiettivo troppo alto ci impedisca di cominciare sin da ora a chiedere che le cose siano diverse.
 Per concludere…
Per concludere…
Se evitiamo di sovraccaricarci di responsabilità, di sentirci in colpa per il welfare pasticciato che rappresentiamo, di sentirci in colpa per le storie delle persone che incontriamo, di sentirci in colpa per non riconoscere i bisogni che i cittadini ci portano… se incanaliamo la nostra insoddisfazione in proposte di cambiamento, se non ci facciamo imbrogliare da chi argomenta che non si può cambiare niente perché tanto non ci sono soldi…
…se proviamo a cambiare prospettiva forse riusciamo a “mettere a terra” un po’ di tensioni e a stare seduti sulle nostre sedie con un po’ più di agio.
Voi che cosa ne pensate?
Pingback: Per un servizio sociale sovra-comunale – Sapere sociale